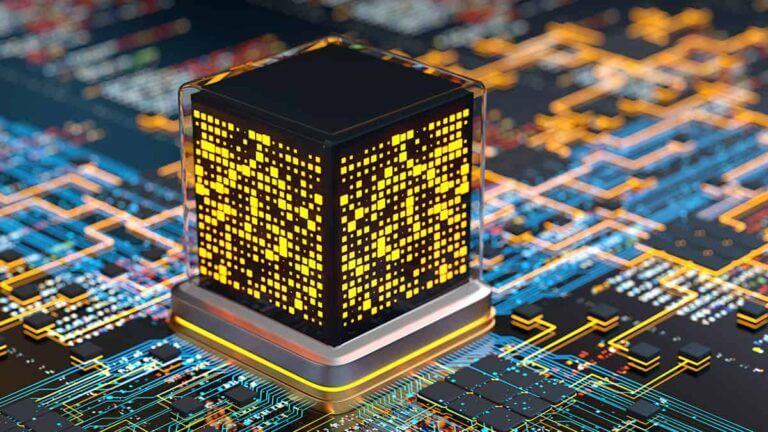L’economista Daron Acemoglu, vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2024 e professore al Massachusetts Institute of Technology, è una delle voci più autorevoli nel dibattito contemporaneo sul rapporto tra innovazione tecnologica, potere e sviluppo sociale. Autore, insieme a Simon Johnson, del volume “Potere e Progresso” (Il Saggiatore, 2023), Acemoglu ha condiviso le sue riflessioni durante un intervento agli “Stati Generali dell’Innovazione 2025”, un evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’Unione Parmense degli Industriali, offrendo una prospettiva critica sulle sfide e le opportunità che l’attuale ondata di innovazioni, in particolare l’intelligenza artificiale, pone alla nostra società.
POTERE E PROGRESSO
Il Nobel Acemoglu: “Progresso tecnologico e benessere sociale non sono necessariamente sinonimi. Ecco perché”
Il progresso tecnologico, inclusa l’AI, non si traduce automaticamente in benessere sociale. L’economista e Premio Nobel Daron Acemoglu sottolinea il ruolo fondamentale delle istituzioni nel guidare l’innovazione verso benefici condivisi. La direzione che prenderà lo sviluppo dell’AI, se sarà orientata a complementare le capacità umane o a sostituirle, dice, è una scelta, non un destino inevitabile. Acemoglu invita poi l’Europa a una doppia sfida: regolamentare l’AI secondo i propri valori democratici senza rinunciare a diventare un polo di innovazione tecnologica…

Continua a leggere questo articolo
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business