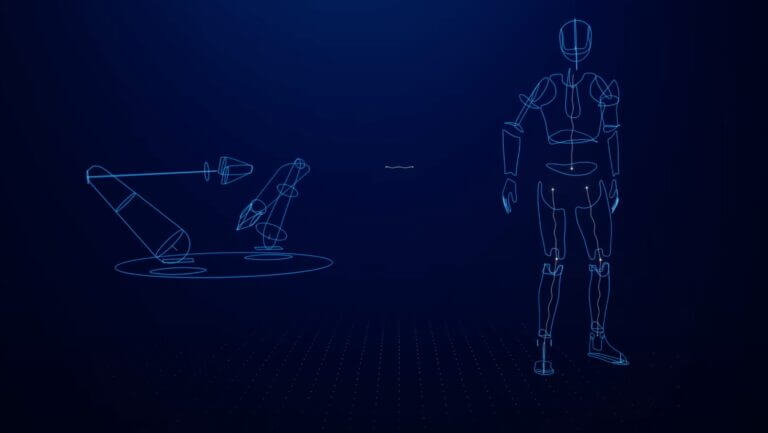L’AI? Altro che eccesso di hype, è una rivoluzione sottovalutata. A dirlo è Eric Schmidt, l’uomo che, come amministratore delegato, ha guidato Google nella sua trasformazione da motore di ricerca al colosso planetario che è diventato sotto la sua gestione nel periodo dal 2001 al 2011, e che è anche un informatico con una profonda comprensione dell’architettura del mondo digitale.
L’OPINIONE
Eric Schmidt (ex Google): “L’hype sull’AI non è eccessivo, anzi: è una rivoluzione sottovalutata”
Secondo Eric Schmidt, ex CEO di Google, l’umanità sta sottovalutando – nel bene e nel male – le potenzialità dell’intelligenza artificiale e la sua capacità di inventare ex novo nuove strategie e soluzioni a problemi finora irrisolti. Schmidt parla però anche dei limiti dell’AI, soprattutto sul piano dell’energia assorbita e della mancanza dei dati per l’addestramento, e mette in guardia dal rischio geopolitico, una “guerra fredda tecnologica” tra USA e Cina, dove la corsa alla super-intelligenza potrebbe portare a un catastrofico attacco preventivo. Nonostante i pericoli, le promesse in campo scientifico e medico sono immense. L’invito del Guru è ad…

Continua a leggere questo articolo
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business

ROBOTICA
-

Boston Dynamics, l’umanoide Atlas entra in fabbrica: primi test sulle linee di produzione Hyundai
22 Gen 2026 -

Il mercato dei robot mobili in forte crescita almeno fino al 2030
13 Gen 2026 -

Dall’integrazione con l’AI agli umanoidi: i 5 trend che guideranno la robotica nel 2026 secondo l’IFR
09 Gen 2026 -

Debutta a Las Vegas Gene.01, l’umanoide italiano che punta a logistica e manifatturiero
08 Gen 2026 -

B&R amplia la gamma di robot con il nuovo antropomorfo Codian AR
08 Gen 2026